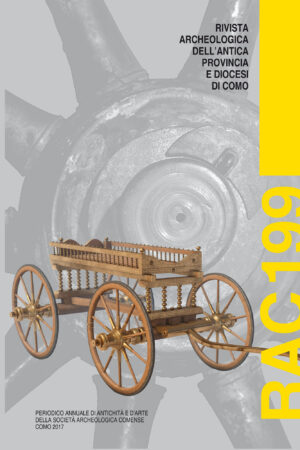Descrizione
A cura di Barbara Grassi (Barbara Grassi, Fiorenza Gulino, Dominic Salsarola, Paul Blockley, Fulvia Butti, Elena Monti, Giordana Ridolfi)
Il lato orientale delle mura romane di Como: rinvenimenti dagli scavi 2020-2021
pp. 5-42
RIASSUNTO
Negli anni 2020-21 alcune indagini archeologiche hanno interessato il lato orientale delle mura romane di Como. Partendo da sud:
– in Via Balestra uno scavo molto limitato ha individuato una porzione di struttura che potrebbe appartenere ad una torre semicircolare, perciò databile all’epoca tardoantica in base a confronti con altri rinvenimenti
– in Via Vittorio Emanuele 15, sono stati rinvenuti un tratto della cinta muraria romana e la base a gradini di una torre tardorepubblicana, che ha un corrispondente nella torre della medesima epoca visibile in Via Carducci. Alcune parti delle opere antiche furono intonacate e si suppone perciò che esse furono sfruttate in epoca romana per uso abitativo, come fu riscontrato anche nei giardini dell’attuale Museo Civico, in uno scavo del XIX secolo. Le prospezioni geofisiche, effettuate precedentemente all’assistenza archeologica, hanno evidenziato un’anomalia, che potrebbe essere rapportata allo sviluppo della torre sia verso est che in alzato.
In quest’area le attività edilizie si sono sviluppate nei secoli fino all’epoca post-medievale moderna, offrendo un minore testimonianza costruttiva solo durante l’epoca medioevale.
– in Via Via Bellini 10/Via Vittorio Emanuele II 53 è stata documentata per la prima volta la sezione delle mura romane, larga circa 2 m; il muro è costituito da due paramenti in pietra locale, con riempimento. Lo scavo è l’unico ad avere restituito dei reperti: si tratta di frammenti ceramici che vanno dall’epoca romana alla postmedievale.
-in Via Porta 13 un intervento molto limitato ha individuato un muro (medievale o successivo) che, per la sua posizione, si ritiene si possa impostare sulla cortina romana.
Tutti i rinvenimenti (attuali e precedenti) permettono di meglio definire la struttura della cinta muraria romana di Como, anche in rapporto alla linea della costa del lago, e la sua evoluzione nel tempo. Infine, le informazioni raccolte dalle indagini esposte contribuiscono a fornire una corretta collocazione per eventuali futuri interventi e/o studi pertinenti al circuito difensivo comasco.
ABSTRACT
Between 2020 and 2021, several archaeological surveys that focused on the eastern side of Como’s Roman town walls were carried out. Starting from the south:
- In Via Balestra, a very limited excavation identified a segment of structure that could be part of a semicircular tower. Comparative analysis has dated it to the late Roman period.
- In Via Vittorio Emanuele II, 115, a section of the late Repubblican walls and the base of a difensive tower were uncovered. Both structures belong to the same period as another tower that was brought to light in the 1950s and is still visible in Via Carducci. A portion of the town walls was plastered, suggesting that the area was repurposed for residential use during the Imperial period, as recorded in the adjacent gardens of the civic museum during excavations in the 19th century. A preliminary geophysical survey adjacent to the defensive tower revealed a “hot spot” that strongly suggests that the tower evolves in an eastward and vertical direction. With the exception of the medieval period, the area preserves a construction sequence that runs from the end of the first century BCE up to the modern era.
- In Via Bellini, 10/Via Vittorio Emanuele II, 53, a cross-section of the town walls was recorded for the first time. The structure, approximately 2 meters in width, consisted of two local stone facings that enclosed a central fill. This is the only intervention to produce finds, ceramics from the Roman to the post-medieval period were recovered.
- In Via Porta, 13 a very limited survey identified a wall dating to the medieval period or later which, due to its location, is believed to have been built directly above the town’s original walls.
All findings, both current and previous, enhance the understanding of Como’s earliest walls. This includes their relationship to the lake’s shoreline and its dynamics over time. Albeit, the four above interventions have offered useful information for the targeting of future investigations and studies along Como’s Roman defensive circuit.
Stefania Jorio
Como: anfiteatro o teatro. Dilemma risolto?
pp. 43-54
RIASSUNTO
Agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso, nel corso di una ristrutturazione in via Vittani 10 (Como) emersero strutture archeologiche disposte a raggera e collegate a plinti parallelepipedi in ghiandone. Attraverso sondaggi geognostici si documentò che le strutture poggiavano su una potente platea di fondazione a sua volta realizzata su pali lignei. Basandosi anche su uno studio geometrico le strutture furono attribuite ad un teatro. Questa posizione non fu condivisa da tutti gli studiosi di cui alcuni optarono per ricondurre i ritrovamenti ad un anfiteatro. La questione è stata riaffrontata nel 2012 con un intervento archeologico nella porzione di isolato contrapposta alla precedente, intervento limitato dalle necessità progettuali e di sicurezza. Si sono intercettate nuove strutture di tecnica edilizia, materiali, quote assimilabili alle precedenti e pertanto appartenenti allo stesso edificio; l’ubicazione fa propendere chi scrive verso l’identificazione in un anfiteatro. Entrambi gli interventi furono condotti dalla Soprintendenza competente.
ABSTRACT
At the beginning of the nineties, during construction work in via Vittani 10, a series of ancient structures were found. The parallelepiped plinths made of “ghiandone” were arranged in a radial pattern. Geognostics surveys revealed that the plinths were built on a thick foundation layer which was supported by wooden posts. Some scholars, based on geometrics analyses, thought the remains to be part of a theatre whereas other archaeologists opted for an amphitheater. The discussion came up again in 2012 with an excavation on the opposite side of the block. Unfortunately the intervention was limited for various practical reasons connected to the building site. New remains with similar building techniques, materials and depth indicate that it was probably the same building. The position within the ancient city brings one to hypothesize that it was indeed an amphitheater. Both excavations were done by the Soprintendenza Archeologica.
Marco Biraghi
Un capitello gettato nell’area dell’anfiteatro
L’articolo è un addedum all’articolo precedente; l’autore propone un confronto con un piccolo capitello del palazzo vescovile di Como, più integro, datato tra il IX e l’XI secolo.
Omar Larentis
Nuovi dati osteologici sul rituale funerario golasecchiano
Il ruolo dell’identificazione tassonomica del tessuto osseo cremato in sezione sottile nell’analisi dei contesti funerari a cremazione
pp. 55-68
RIASSUNTO
La differenziazione tra ossa umane e ossa non umane nei contesti archeologici a cremazione rappresenta una sfida complessa, così come la successiva identificazione tassonomica, auspicabile per meglio comprendere la natura dei resti e il loro significato nel rituale. A tal fine, la sola analisi morfologica dei resti è spesso parziale quando non sufficiente. Maggior rilievo riveste l’analisi istologica dei campioni, sebbene meno praticata in quanto distruttiva, più dispendiosa in termini di tempo e di denaro e bisognosa di maggiori e più settoriali competenze degli operatori.
Questo studio è stato effettuato su 314 individui cremati della Civiltà di Golasecca (900-375 a.C.) rinvenuti in 298 tombe provenienti dal Piemonte orientale alla Lombardia occidentale. L’analisi morfologica dei frammenti cremati ha permesso di selezionare 246 campioni di tessuto osseo da cui sono state elaborate altrettante sezioni sottili al fine della valutazione istomorfometrica dei preparati. Lo studio ha affrontato in modo critico i problemi principali legati all’identificazione tassonomica dei resti cremati, proponendo una metodologia di ricerca testata su un campione protostorico italiano. Dall’analisi istologica è stata identificata la presenza di elementi ossei non umani nelle sepolture, mentre un’analisi meramente morfometrica non era stata in grado di riconoscerli. Inoltre, l’identificazione tassonomica ci ha permesso di proporre nuove ipotesi sulla presenza e sull’uso degli animali all’interno del rito funerario golasecchiano.
ABSTRACT
The differentiation between human and non-human bones in cremation archaeological contexts poses a complex challenge, as does the subsequent taxonomic identification, which is crucial for a deeper understanding of the nature and significance of the remains within the ritual. In this regard, sole morphological analysis of the remains is often partial, if not insufficient. Histological analysis of samples, although less commonly practiced due to its destructive nature, greater time and financial investment, and the need for specialized expertise, holds greater significance.
This study focused on 314 cremated individuals from the Golasecca Civilization (900-375 BC) found in 298 tombs spanning from eastern Piedmont to western Lombardy. Morphological analysis of the cremated fragments enabled the selection of 246 bone tissue samples, from which an equal number of thin sections were prepared for histomorphometric evaluation. The study critically addressed key issues related to the taxonomic identification of cremated remains, proposing a research methodology tested on an Italian Protohistoric sample. Histological analysis revealed the presence of non-human bone elements in the burials, whereas a purely morphometric analysis had failed to recognize them. Furthermore, taxonomic identification allowed for new hypotheses regarding the presence and use of animals within the Golasecca funerary ritual to be proposed.
Serena Zoia
L’ossuario romano del monte Sangiano
pp. 69-76
RIASSUNTO
Alla fine degli anni ‘60 un ossuario di epoca romana venne ritrovato nel corso di scavi condotti presso la chiesa di San Clemente sul monte Picuz, nel territorio di Caravate (Varese). Si propone qui un riesame dell’iscrizione e del suo supporto, nonché un tentativo di ricostruirne l’originaria collocazione, anche alla luce delle testimonianze epigrafiche e archeologiche emerse nei comuni vicini, in particolar modo Leggiuno.
ABSTRACT
At the end of the 1960s, an ossuary dating to the Roman period was found during excavations at the church of San Clemente on Mount Picuz, in the territory of Caravate (Varese). This paper aims to propose a re-examination of the inscription and its support, as well as a reconstruction of its original location, also in the light of epigraphic and archaeological evidence that has been found in neighbouring areas, especially in Leggiuno.
Fulvia Butti
La necropoli romana di Airolo-Madrano (Canton Ticino). Scavi 2016
pp. 77-138
RIASSUNTO
La necropoli romana di Airolo-Madrano è situata ai piedi del San Gottardo, e fu scavata in tappe successive: le tombe del 1957, 1965 e 1966 furono edite dalla scrivente nel 2000, e in questo articolo sono aggiunte 5 tombe reperite nel 2016. Questo ultimo rinvenimento ha indotto a riconsiderare tutti i materiali nel loro insieme, alla luce dei recenti studi.
La popolazione del villaggio appare ben inserita nei commerci dell’impero romano, ma le donne sono molto conservatrici e indossano l’abito di tradizione celtica ancora agli inizi del III secolo. Un aspetto notevole sono le numerose fibule: alcune sono tipiche della popolazione dei Leponti (fibule di tipo Mesocco); altre, smaltate, sono di provenienza transalpina.
Questa comunità mostra perciò un forte legame con la zona a nord delle Alpi, in particolare con il Vallese.
ABSTRACT
The Roman necropolis of Airolo-Madrano is located at the foot of Mount Saint Gotthard and was excavated in successive stages: the tombs from 1957, 1965, and 1966 were edited by the writer in 2000, while 5 tombs found in 2016 have been added in this article. This latest discovery has led to a reconsideration of all materials as a whole, in light of recent studies. The population of the village appears to have been well integrated into the trades of the Roman Empire, but the women were very conservative and still wore Celtic traditional dress at the beginning of the 3rd century. A notable feature is the numerous fibulas: some are typical of the Leponti population (Mesocco-type fibulas); others, enameled, come from across the Alps. This community therefore seems to have had a strong connection to the area north of the Alps, particularly with the Valais.
Erika Amati
La struttura medievale del Palazzo Vescovile di Como (secoli XIII-XIV)
pp. 139-150
RIASSUNTO
La vicenda architettonica del palazzo vescovile di Como, costruito verso l’inizio dell’XI secolo e sottoposto a innumerevoli rimaneggiamenti nel corso del tempo, si presenta di difficile lettura. Lo studio di fonti documentarie inedite relative al patrimonio immobiliare urbano della Chiesa episcopale comasca permette di apportare nuovi elementi e chiarimenti sulla sua struttura nei secoli XIII e XIV.
ABSTRACT
The architectural history of the bishop’s palace in Como, built around the beginning of the 11th century and subjected to countless alterations over time, is difficult to read. The study of unpublished documentary sources relating to the urban real estate of the Episcopal Church of Como provides new elements and clarifications on its structure in the 13th and 14th centuries.
Pietro Mecozzi
La tintoria rinascimentale di piazza Volta a Como
pp. 151-164
RIASSUNTO
L’articolo tratta del rinvenimento, avvenuto nel 2018 in piazza Volta a Como, di un impianto artigianale di epoca rinascimentale. All’interno di alcuni vani della Casa Vietti-Rovelli è venuta alla luce una serie di strutture circolari e semicircolari caratterizzate da forte alterazione termica delle superfici. L’analisi e il confronto del contesto archeologico con le fonti storiche hanno permesso di interpretare tali strutture come caldaie per la tintura dei tessuti, offrendo un’evidenza concreta della tradizione tessile della città in età pre-industriale.
ABSTRACT
The paper discusses about a Renaissance craft area found in piazza Volta, Como, in 2018. Inside the Vietti-Rovelli house excavations have shown the presence of circular and semicircular structures with burned surfaces. Analysis and comparison of the archaeological context with historical sources have lead to interpret these structures as dyeing boilers. This finding gives concrete evidence of the textile tradition of the city before the industrial era.
Daniele Pescarmona
Dai Sacri Monti a Cremona: tre casi di Cristo spirante in scultura nel settimo decennio del Seicento (Dionigi Bussola, Agostino Silva, Giovan Battista Barberini)
pp. 155-174
RIASSUNTO
Il tema iconografico barocco del Cristo spirante è stato studiato ed è conosciuto in scultura prevalentemente grazie a crocifissi di piccole dimensioni fusi in bronzo o scolpiti in avorio, appartenenti a mute d’altare di chiese o ad altaroli domestici. Esistono però anche statue di Cristi spiranti di grandezza monumentale. Nell’articolo si considerano quelle realizzate nel volgere di pochi anni nel settimo decennio del Seicento nei Sacri Monti di Domodossola, Varese e Ossuccio e nella chiesa di Sant’Agostino di Cremona.
ABSTRACT
The Baroque iconographic theme of the “Expiring Christ” has been explored and is predominantly known in sculpture through small bronze or ivory crucifixes, often part of church altar sets or domestic shrines. Notably, monumental statues of the Expiring Christ also exist. This article delves into those created in the space of a few years in the seventh decade of the 17th century in the Sacred Mountains of Domodossola, Varese, and Ossuccio, as well as in the church of Sant’Agostino in Cremona.
Rita Pellegrini
Doni degli emigrati alla patria: oreficerie tedesche settecentesche a Torno e a Palanzo
pp. 175-192
RIASSUNTO
Nel XVIII secolo le comunità di Torno e di Palanzo furono interessate da un flusso emigratorio verso l’Europa centro-settentrionale. Come per altre località della diocesi di Como, gli emigrati offrirono in dono al paese natale alcune suppellettili che andarono ad arricchire il patrimonio delle chiese locali.
Nel presente studio si prendono in considerazione, fra tali beni, le oreficerie settecentesche di area germanofona, realizzate in modo particolare ad Augsburg. Per ciascuno dei due paesi viene proposto un quadro storico dell’emigrazione settecentesca, ricostruito grazie a documenti dell’epoca che consentono di comprendere le principali caratteristiche del fenomeno. Di seguito, si analizzano alcune suppellettili liturgiche, offerte dagli emigrati e ancora custodite a Torno e a Palanzo, esaminate attraverso una specifica scheda storico-critica.
ABSTRACT
In the Eighteenth century the centers of Torno and Palanzo were involved by a migration flow in central-northern Europe. As members of other locations in the diocese of Como did, emigrants offered to their birthplace some liturgical furnishings which enriched the heritage of local churches.
This study analyses, withing these furnishings, the sacred goldsmith works from the germanophonic area of the eighteenth century, especially those crafted in Augsburg. For each of the two villages a framework of the migration flows in the eighteenth century will be exposed, reconstructed through documents of that time that allow to understand the main characteristics of the phenomenon. Then, a few liturgical furnishings offered by the emigrants, still treasured in Torno and Palanzo, will be analysed through a peculiar historical-critical review.
Alessio Maria Camarda Signorino
“…de presenti Panormi Insulae Regni Sicilie degente…”.
La famiglia Riella, tra emigrazione lariana e naturalizzazione palermitana cum domo et familia
pp. 193-214
RIASSUNTO
Il focus della ricerca è incentrato sulla dossolirese famiglia Riella e sul passaggio della stessa dall’Alto Lario a Palermo, con successivo accesso, anche maritali nomine, al ceto dirigente della ‘Felicissima’ città di Palermo. Con questi presupposti si sono voluti ricostruire tutti i vari passaggi, analizzando censo e alleanze matrimoniali, onde comprendere l’iter di naturalizzazione isolana della famiglia e fino al confluimento del ramo principale in altri casati che, per un periodo più o meno lungo, hanno portato anche il cognome Riella.
ABSTRACT
The focus of this reserch is on the Riella family from Dosso del Liro and its passage from Alto Lario to Palermo, with subsequent access, also by marriage, to the ruling class of the ‘Felicissima’ city of Palermo. With these assumptions, it was intended to reconstruct all the various passages, analyzing census and marriage alliances, in order to understand the process of naturalization of the family in Sicily and up to the merger of the main branch into other lineages that, for a more or less long period, also bore the surname Riella.